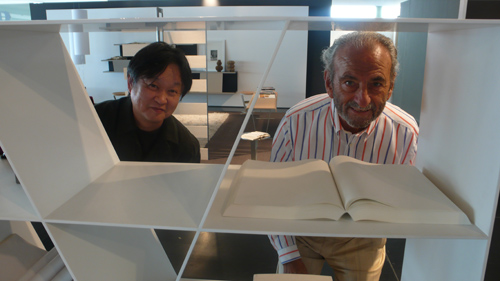Luglio 10th, 2015, category: Blog,

Da giorni resisto al commento sulla “vecchia” nuova Alfa Giulia. In quanto mi interessano alcune riflessioni più generali, evito le valutazioni puntuali, che lascio ai più periti e tecnici, ma non si può non dire che “non c’entra niente con l’Alfa”; ovvero che si tratta di un’auto aggressiva e forse un po’ cafona, non particolarmente originale (come peraltro il restyling piatto e commerciale del marchio) con pesanti affinità ad esempio con Bmw serie 3 o altro a scelta, lontana da ogni riferimento al family feeling storico di Alfa, fatto di sportività ed eleganza (come ancora ben testimoniava, ormai oltre un ventennio orsono, la 156 del rilancio di Walter De Silva, non a caso da tempo all’Audi).
La favola che “è quello che vuole il mercato” (quale mercato? quali consumatori? conta la domanda oppure l’offerta?) ormai non si può più raccontare nemmeno ai bambini. Certo il mondo è cambiato; la gestione Marchionne ha ben poco interesse per il progetto, ma almeno il concetto di brand identity dovrebbe suggerire qualcosa al mondo marketing (e financial) driven del gruppo Fca. Non interessa qui entrare nella questione se un certo modo di intendere l’azienda abbia salvato o meno Fiat; preme invece sostenere (e il discorso vale per molte imprese con analoghe impostazioni) come una buona gestione economica (reale o presunta) non sia necessariamente incompatibile con un buon design, esito fra l’altro non solo di un mixing di singoli elementi derivati da modelli di successo presenti sul mercato, inevitabilmente disorganici e disarmonici.
Ignorare la presentazione dell’Alfa Giulia diventa però impossibile nel momento in cui si apprende, in questi giorni, della vendita definitiva ai tedeschi di Audi di Italdesign, la società di progettazione di Giorgio Giugiaro, uno dei maggiori car designercontem
poranei, autore di autentici long sellers, come Golf, Panda, Uno e Punto, insomma anche di tutte le ultime Fiat di successo. Scontato rilevare che si tratta di un ennesimo pessimo segnale per l’industria e per il car design italiano. Una grave perdita (ultima della crisi-dismissione di molte aziende del settore del design, di gruppi auto e motociclistici in Italia) maturata nel tempo e passata piuttosto sotto silenzio nel mondo delle imprese (dove sono finiti imprenditori e ‘capitali coraggiosi’ in Italia?), delle associazioni di categoria industriale (di cui sono da tempo evidenti i limiti nel farsi portatori di un’idea forte di ‘cultura d’impresa’, ma anche di strategia, forza e autonomia), dei media (a quando un ragionamento su scarso coraggio e vocazione ‘pubblica’ di stampa e televisione, nonché intellettuali, nostrani?).
Dentro l’obbligata dimensione internazionale (per cui forse a volte marchi italiani funzionano meglio in mani straniere) e un sistema socio-economico-culturale in velocissima trasformazione, per il nostro Paese continua a non essere riconosciuta – da parte di politica, industrie, luoghi della ricerca, opinione pubblica – la centralità di una riflessione profonda (non improvvisata, strumentale o anacronistica) sui temi dell’impresa e del lavoro(e della formazione), seguita da investimenti strutturali di medio e lungo periodo. Si tratta fra l’altro del fondamento di una politica progressista, che non può che essere vocata innanzitutto a superare le attuali intollerabili condizioni di diseguaglianza socio-economico-culturale etc.
Non è sempre vero che i soldi non ci sono, la questione è dove si impiegano. Pare che manchino per investire in ricerca e innovazione (scontato ricordare che tutto il settore dell’automobile produce da tempo vetture ibride e molto altro, ma non Fca) e pagare un designer per realizzare una Giulia di buon progetto, ma ci siano invece per andare alla conquista del mercato con campagne pubblicitarie, immagino non gratuite ma di certo non propriamente memorabili (a base di decotti testimonial oppure financo offensive e volgari).
Progettazione e produzione di mezzi di trasporto (automobili, moto, biciclette, treni etc.) sono stati in Italia ‘motori’ fondamentali e riconosciuti nel mondo; hanno generato economie, lavoro e benessere: cosa ne rimane oggi? Fra le altre cose, Italdesign è stata venduta e noi abbiamo la “nuova” Giulia.
pubblicato su “il fatto quotidiano”, 10 luglio 2015
Giugno 22nd, 2015, category: Blog,
Comparso un paio d’anni fa soprattutto nelle città d’arte, proposto a basso prezzo da venditori ambulanti, è divenuto ormai almeno nel nostro Paese un fenomeno diffuso, intercettato ora anche dalla produzione industriale e dalla distribuzione commerciale più allargate. Stiamo parlando del bastone su cui montare lo smartphone per fare autoscatti fotografici o autoriprese video, allo scopo di consegnare se stessi e i momenti esaltanti (reali o presunti) della propria vita alla storia o, più banalmente, ai social network condividendoli con una cerchia ristretta oppure planetaria di followers.
Non interessa qui aprire una riflessione su caratteri culturali, sociali, psicologici, estetici di tale pratica, su cui molti si sono già espressi e su cui ognuno può vantare opinioni legittime.
Meno affrontata la questione dei caratteri di questa tipologia di oggetto. Si tratta di un prodotto low cost, tendenzialmente usa e getta, di qualità formale e funzionale modesta, divenuto però un autentico best seller.
La cosa aiuta a riflettere sulla condizione – per dirla in modo articolato e colto ma utile – degli artefatti estetici dentro l’’economia del simbolico‘. Cioè su come i prodotti nel mercato capitalistico esistano al di là della corrispondenza a una funzione oppure della stretta relazione costo-valore, bensì trovino modalità privilegiata di valorizzazione attraverso la costruzione e stimolazione di un immaginario simbolico, evocativo, emozionale. Insomma non si compra (solo) quello che ci serve (abbiamo quasi tutto e di certo abbastanza, almeno in Occidente) ma ciò che ci racconta storie, solleticando fantasia, sogni e desideri.
Il successo del business del selfie stick intercetta infatti alcune ‘necessità’ anche simboliche e ne esemplifica le conseguenze: risponde all’esigenza di fotografarsi (e poi ‘mettersi in vetrina’) ottenuta con un gadget di costo e qualità ridotti, destinato a divenire in fretta l’ennesimo scarto dentro un sistema globale senza troppo controllo per quanto riguarda crescita infinita e sostenibilità.
Si tratta di un prodotto che nasce e si afferma fuori dalle logiche delle ‘scientifiche ricerche di mercato basate sulle presunte domande dei consumatori, ma anche dalle raffinatezze della cultura del brand o del design. Una sorta di progetto ‘dal basso’ caratteristico dei tempi della rete e del digitale, della proliferazione, diffusione e democraticizzazione degli strumenti di progetto-produzione-distribuzione-comunicazione-consumo. Analogo, solo per fare alcuni esempi, ad altri fenomeni solo apparentemente lontani e differenti, come street fashion, autoproduzione e Diy, tribù di consumo autoriferite e autogestite fino ai Gas, gruppi di acquisto solidale.
L’oggetto dell’anno allora può dire forse qualcosa a chi si occupa di progetto, produzione e consumi. Ad esempio, che il processo di costruzione delle merci contemporanee presenta una complessità non esauribile nelle modalità dell’approccio tecnico-scientifico di finanza e marketing bensì vive di spunti, stimoli e sollecitazioni che arrivano dalle persone e richiedono la messa a punto di strumenti di intelligenza più sofisticati, insondabili, che guardino non solo le economie ma anche le necessità (fino alle più opinabili come quelle dei selfie), nonché le aspirazioni più alte della società.
Achille Castiglioni, uno dei più importanti designer italiani, consigliava spesso ai suoi giovani studenti: “andate a spasso per le strade e per i prati, a vedere un po’ come è fatto il mondo; le idee sono già tutte lì, pronte per essere colte”; e proseguiva “se non siete curiosi, lasciate perdere”.
pubblicato su “Il fatto quotidiano”, 22 06 2015
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/06/22/il-bastone-da-selfie-e-loggetto-dellanno/1799121/
Dicembre 19th, 2014, category: Blog,
così io scrivevo sul domenicale del “sole 24 ore” nel 2007:
“Il design, i suoi temi e protagonisti hanno conosciuto negli ultimi anni una crescente esposizione sui media generalisti e new media, uscendo dall’ambito specialistico cui erano stati relegati o autorelegati. Un’esplosione d’attenzione non senza equivoci che spesso (fra)intende con il termine design cose assai differenti, anche un po’ alla moda, ma certo salutare per “uscire dal ghetto” e comunicarsi. Fra l’altro, ciò ha comportato una necessità di ripensamento e riposizionamento delle riviste di settore, oltre che l’invenzione di modi rinnovati di parlare delle questioni del progetto per la produzione. Testimonianza recente della prima esigenza, ad esempio, sono le nuove direzioni di storiche testate come “Domus” e “Abitare”, che dalla primavera saranno guidate rispettivamente da Flavio Albanese e Stefano Boeri, e per cui si prospettano significativi mutamenti di rotta editoriale e culturale. Ma non sono mancate altre modalità di inglobare il design in un approccio diverso e ampio. “Wallpaper”, ad esempio, non è una rivista dedicata in senso stretto, ma dalla sua nascita nel 1996 è stata riferimento per la comunità internazionale dei “creativi”; ha attratto importanti economie e il sostegno di numerose aziende. Tyler Brulé, che aveva ideato “Wallpaper” (lasciata nel 2002), si ripresenta ora con una nuovo magazine “Monocle”, il cui primo numero è in edicola in questi giorni (affiancato da sito e tv; editor Andrew Tuck, creative director Richard Spencer Powell, pubblicato da Winkontent di Londra), destinato di sicuro ad aprire a un inedito “punto di vista”. “A briefing on global affairs, business, culture & design” recita il payoff della testata di castigata grafica che reca in copertina un militare pilota d’aereoplano, omaggio al servizio d’apertura dedicato alla marina giapponese. In apparenza non proprio glamour (a differenza degli inserzionisti che sono i maggiori marchi della moda e qualcuno del design), in realtà la proposta è di un modo a largo spettro di guardare le questioni, muovendo dal generale/global per arrivare al particolare/design; all’insegna di un taglio giornalistico con lunghi servizi da leggere e una rigorosa scelta di contenuti (“free of PR-driven content”, dichiarano). A ben guardare poi si parla di Lego, di vending machine, di computer games scozzesi, di residenza a Rio e San Paolo, e ancora – passando per Pitti uomo – di cosa resta ancora da fare per essere Man of the moment. Per concludere con Edits, una selezione del meglio, dagli acquisti ai luoghi, all around the world. Se diversi ingredienti appaiono certo già noti è il modo di “confezionarli” che è abbastanza diverso, più controllato, riflessivo e cosciente, senza rinunciare a essere accattivante.”
Alberto Bassi su “sole 24 ore”, 2007
oggi 2014 così scrivono:
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2014-12-17/l-editoria-e-crisi-ma-non-brule-e-riviste-qualita-130028.shtml
bene non resta che tenerne conto.
Maggio 14th, 2014, category: Blog,
La Mostra internazionale della produzione in serie alla VII Triennale di Milano del 1940, ordinata e allestita dall’architetto Giuseppe Pagano, è la prima esposizione specificamente dedicata al disegno industriale in Italia. Preparata da altre mostre a diverso titolo collegate, derivata da un’articolata riflessione teorico-disciplinare condotta da Pagano, la mostra era volta a tracciare il panorama italiano di quanto progettato e prodotto “in serie” alla fine degli anni trenta, attraverso una selezione di svariate tipologie produttive, fra cui gli utensili domestici, l’arredamento, la motoristica, gli oggetti tecnologici o le macchine per scrivere. Questa mostra, di cui in questo articolo si ricostruiscono premesse e caratteri nel quadro degli sviluppi del contesto progettuale di Pagano, appariva dunque una sorta di collettiva presa di coscienza e d’identificazione, da parte di designer e industriali, di uno “spazio” e una modalità identitaria per il confronto fra cultura d’impresa e cultura del progetto. Da diversi punti di vista, può essere considerata la data di nascita, assieme simbolica e concreta, del design italiano.
Read the rest of this entry
Aprile 9th, 2014, category: Blog,
Alla Fiera milanese emergono differenti strade e situazioni imprenditoriali, perlopiù di piccola dimensione produttiva e organizzativa, che hanno identificato nicchie di mercato di qualità trascurate e percorribili
Salone del Mobile e Fuori Salone – che aprono questa settimana a Milano e portano in città progettisti internazionali, aziende e non solo addetti ai lavori – costituiscono sempre una buona occasione per fare il punto sullo stato dell’arte del legame fra cultura del design e imprese, sulla salute delle industrie, le nuove esigenze delle persone, oltre che naturalmente i nuovi prodotti. Almeno un paio le direzioni e i temi divenuti riconoscibili da qualche anno: da una parte la tenuta e conferma delle aziende in salute, più o meno storiche, che hanno affrontato la fase transitoria con una precisa identità, chiarezza di intenti e riconoscibilità di prodotto; dall’altra l’emergere di differenti strade e situazioni imprenditoriali, perlopiù di piccola dimensione produttiva e organizzativa, che hanno identificato nicchie di mercato di qualità trascurate e percorribili.
Sullo sfondo, non senza qualche equivoco teorico e operativo, le opportunità che si sono aperte attorno ai modi dell’autoproduzione, cioè di un progettare e fare esterno o ai margini dei sistemi economici correnti, alla ricerca di un altro modello per far dialogare prodotti, utilizzatori e la società nel suo complesso. In questo contesto il nodo da sciogliere sembra essere se guardare indietro o avanti. Cioè se alimentare il rimpianto di una possibilità in sostanza pre-industriale e invocare un’idea salvifica di artigianato – che di suo ha già in larga misura fallito il confronto con i nuovi tempi –, oppure riflettere su come altre modalità di progettare-produrre-comunicare-vendere (siano artigianali, digitali o entrambe le cose) possono stare, in modo utopico o riformista, “dentro il mondo”.
Read the rest of this entry
Marzo 1st, 2014, category: Blog,

Una buona idea di cui si è ritornato a parlare: la riapertura del Museo storico dell’Alfa Romeo di Arese, a due passi dai siti della prossima Expo 2015.
Aperto nel 1976 – nel contesto di una serie di importanti architetture di fabbrica e di servizi, fra gli altri di Ignazio Gardella, Giulio Minoletti, Vito e Gustavo Latis, le cui vicende complessive sono ben ricostruire da Jacopo Gardella – il Museo Alfa è stato uno dei primi musei d’impresa italiani, allora voluto fortemente da Giuseppe Luraghi, appassionato presidente dell’Alfa Romeo, e raccoglie oltre un centinaio di auto storiche, documenti, filmati, memorabilia e così via. In senso lato, rimane “documento” fisico di uno dei capitoli fondamentali della storia dell’industria e del lavoro nel nostro Paese. Ma anche un esempio di cultura di fabbrica da esibire in una fase storica in cui serve ripensare con vigore le radici imprenditoriali del nostro Paese.
Dal 2011 è stato chiuso da Fiat, attuale proprietaria del marchio, ufficialmente per motivi di manutenzione, in verità pochi giorni dopo che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali aveva posto sotto tutela l’area e gli edifici. Ora l’azienda è uno degli sponsor di Expo 2015 e l’occasione sembra appropriata per affrontare in maniera differente la questione del Museo.
Alfa Romeo nel corso della sua storia ha progettato – spesso in collaborazione con carrozzieri e car designer – e prodotto molte vetture entrate nella storia mondiale dell’automobile. Le principali, assieme a molte altre, rare e uniche, sono conservate proprio ad Arese, in quello che è un autentico Museo del car design italiano. In tutto il mondo il marchio gode di enorme e meritata reputazione, con appassionati disposti a qualunque cosa per vedere dal vivo queste automobili. Scontato appare il successo che verrebbe tributato dai visitatori al Museo. Cosa si aspetta dunque?
Non entriamo qui nel merito generale dei contenuti dell’Expo, la cui definizione e concretizzazione in questi anni sembra aver seguito percorsi non sempre lineari, ma la riapertura definitiva del Museo Alfa – rispetto ad altre in cui ci si è imbarcati in questa infinita preparazione all’”evento” – è una cosa relativamente semplice, non molto costosa, che si può fare in fretta. Basta volerlo.
Per quanto riguarda il riferimento al tema generale della manifestazione “nutrire il pianeta” – e che non sembri in nessun modo una battuta – : finché è stata aperta, la fabbrica dell’Alfa Romeo di Areseha dato lavoro e da mangiare a tanta gente.
pubblicato in “Il fatto quotidiano”, 1 marzo 014
Gennaio 29th, 2014, category: Blog,
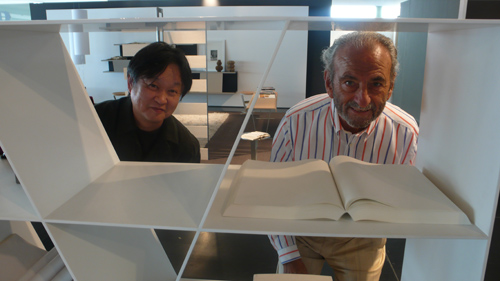
È mancato in questi giorni Piero Ambrogio Busnelli, fondatore di B&B una della più importanti industrie del design italiano. Nel 1966 aveva avviato a Novedrate, fra Meda e Cantù nel cuore della Brianza produttiva, l’azienda C&B – assieme a Cesare Cassina, altra figura fondamentale dell’imprenditoria dell’arredamento –, divenuta poi nel 1973 B&B, facendo fin da principio gravitare la sua attività attorno ad alcuni elementi chiarissimi: ricerca, innovazione e design, declinate in una dimensione industriale. Quindi cercare nuove soluzioni e organizzazioni produttive, modalità di affrontare il mercato, sorrette da un ruolo del progetto, assieme innovativo e praticabile. Sostenuti dalla capacità di visione, rischio e allo stesso tempo concretezza di Busnelli, dalla funzione decisiva del “leggendario” Centro Ricerche e Sviluppo B&B, moltissimi designer italiani e internazionali hanno progettato arredi di qualità, successo e diffusione. Fra questi, Marco Zanuso, Gaetano Pesce, Vico Magistretti, Mario Bellini, Antonio Citterio, Patricia Urquiola o Naoto Fukasawa. Senza contare il coinvolgimento di importanti architetti da Afra e Tobia Scarpa a Renzo Piano, a grafici – da Enrico Trabacchi a Pierluigi Cerri – e fotografi, come Oliviero Toscani, di cui rimase famosa la provocatoria compagna pubblicitaria per il divano Bambole.
Al di là del valore assoluto della sua figura, la scomparsa di Busnelli fornisce occasione per una riflessione sull’imprenditoria in Italia. Senza rimpianti passatisti, ma con il pensiero alla necessità che nel nostro Paese si torni a parlare ma soprattutto a fare per l’impresa e per il lavoro. Gran parte di quella generazione di industriali usciti dalla guerra con un’energia e ideali forti, non solo nel settore nell’arredamento, è ormai venuta a mancare; dentro mutati contesti e condizioni complessive, il “capitalismo familiare” italiano, caratteristico delle piccole e media industrie, ha talvolta faticato a reggere il passo con i nuovi tempi e a rinnovare i modi gestionali, organizzativi, oltre agli stessi modi di intendere l’impresa, in questo certo poco sostenuti dal complessivo Sistema Paese.
Può essere allora davvero rilevante per l’economia del nostro Paese, analizzare in profondità i caratteri del lavoro di Busnelli – fondati su spirito imprenditoriale, investimento in ricerca e sviluppo, tensione all’innovazione, all’essere first movers, anche attraverso il ruolo del progetto – e rileggerli in chiave contemporanea, identificando e sostenendo, dal punto di vista economico, legislativo e culturale, una nuova generazione di industriali o rinnovati modi di fare impresa design driven. Per “un Rinascimento manifatturiero”, come l’ha definito di recente Antonio Calabrò.
pubblicato in “il fatto quotidiano” 29 gennaio 2014
Dicembre 8th, 2013, category: Blog,
In questi giorni ferve in rete il dibattito sull’ennesimo disastro della grafica pubblica fai-da-te, attorno al marchio per il centocinquantenario di Firenze capitale d’Italia, ritirato e sostituito a pochi giorni dalla presentazione. Un pasticcio visivo, di segni e linguaggi, ma soprattutto di leggibilità, che nel caso di un marchio non è poco rilevante.

(Nell’immagine, in alto il marchio fiorentino presentato e ritirato; in basso uno assai “simile” di un paio d’anni fa).
La questione è sempre la stessa e si propone non solo con la gestione casalinga della progettazione visiva ma anche con l’impiego ormai divenuto perverso di diversi tipi di Concorso. Questo vale per il settore pubblico, per cui siamo noi a mettere disposizione denari e ci piacerebbe ricevere un qualificato servizio, ma anche per il privato.
In relazione a questo, è scontato ricordare che esiste una professionalità specifica, quella del visual designer, che progetta logotipi, font, immagine coordinate e così via per strumenti e media tradizionali e digitali.
Nel primo caso della gestione casalinga, invece di interpellare uno o più designer, se non se ne dispone di interni, da mettere in competizione o cui affidare un incarico – come del resto avviene in tutte le professioni e nella maggioranza dei paesi del mondo – ci si arrangia in casa con un “brillante” autodidatta o, nei casi fortunati, con un architetto da spendere su più fronti. Sempre più di frequente vengono allora adottati “clip art”, in sostanza materiali già pronti e disponibili in rete cui si apportano lievi modifiche.
È questa la situazione del marchio del centocinquantenario fiorentino, ma gli esempi sono davvero numerosi; purtroppo la norma invece che l’eccezione.
Nel secondo caso, lo strumento del Concorso permette di avere risultati – la cui qualità non pare certo il criterio orientatore – a basso costo con il meccanismo finto democratico della partecipazione allargata. Con le debite differenze e proporzioni, è come se si mettesse a concorso il posto di chirurgo per fare un’operazione: e che vinca il migliore, con buona pace del paziente.
Certo ci sono i concorsi fatti con buone regole e secondo corrette pratiche, come quelli predisposti dalle associazioni di categoria, ad esempio dei visual e industrial designer o dei pubblicitari, ma sono procedure poco frequentate dai committenti perché prevedono, fra l’altro, una chiara definizione degli obiettivi, rimborsi spese per chi partecipa, giurie con competenze, magari senza il politico di turno etc. Insomma, adeguate garanzie per il lavoro svolto.
Se invece il Concorso si limita a richiedere il progetto del solo marchio e a far partecipare tutti, ci sarà poi una lunga fase di sviluppo e di declinazione della sua applicazione che in molti casi avviene poi su incarico diretto, senza gare né concorsi. Chiunque può rispondere alla facile domanda su dove si guadagnano i soldi e si piazzano gli amici.
È più o meno quello che, fatte le necessarie differenze, è avvenuto – fra i purtroppo molti esempi disponibili – dall’inguardabile cetriolo di italia.it al fatto-in-proprio di Magic Italy fino al più recente marchio turistico per la città di Roma o alla gestione demagogica (molte teste senza competenze e idee non sono necessariamente meglio di pochi forniti di tali necessarie caratteristiche, almeno perché è il loro mestiere) di quello in corso per il logo turistico di Firenze, aperto a tutti – 5000 sono stati i partecipanti alla fine – in questo caso attraverso una piattaforma online per lo svolgimento di concorsi. Al vincitore la modica cifra di 15.000 euro; importante per gli organizzatori tentare emulare il mitico “I love NY”, un logo che infatti guarda caso è stato progettato da Milton Glaser, uno dei più importanti grafici contemporanei!
In verità bisogna riconoscere che in tutto ciò i progettisti hanno una certa parte di responsabilità, innanzitutto dal punto di vista intellettuale e professionale: perché non sempre hanno saputo o voluto tutelare e difendere la dignità del proprio lavoro e ruolo. Troppo spesso infatti abbiamo conosciuto comportamenti come minimo ambigui e condiscendenti, in ogni caso poco orgogliosi di un possibile contributo di utilità e servizio per le persone e la società.
Assieme ad altri fattori “ambientali” del nostro Paese – divenuti purtroppo caratteristici ma non certo obbligati, anzi che è necessario combattere – anche questo ha contribuito a rendere più normale “saltare” i professionisti del progetto, di frequente non adeguatamente riconosciuti e rispettati in termini culturali, sociali ed economici.
Ma la questione si pone, in modo particolarmente vistoso appunto in Italia, anche per numerose altre categorie intellettuali, proprio quando ormai è evidente la loro rilevanza e necessità, in un mondo ormai da tempo orientato verso un’“economia della conoscenza”.
L’idea che “Le idee si pagano” – e anche i progetti – come titolava un noto articolo sul Sole 24 ore dell’economista Guido Guerzoni, appare ben lontana da un quotidiano riconoscimento.
Un Paese nuovo può nascere da regole certe, dalla tutela delle competenze, dalla ricerca della qualità. Questo non sempre accade in molti ambiti, fra cui quello della progettazione; quando è pubblica riguarda tutti noi: utile essere avvertiti e accorti.
pubblicato in “Il fatto quotidiano”, 8/12/2013
Ottobre 30th, 2013, category: Blog,

Ben venga una fiction Rai che si occupa di un imprenditore illuminato come Adriano Olivetti. Lascio ad altri il commento sull’operazione complessiva – romanzata, retorica… – o sulla qualità televisiva; interessa guardare come racconta una parte fondamentale del lavoro di Olivetti, quella che lo ha spinto a collaborare, oltre che con innovativi ingegneri e poi intellettuali, filosofi e poeti, con gli architetti, i designer e i grafici. Questa idea di impresa – fra le altre cose – aperta e dialogante alla cultura e alle sue manifestazioni più avanzate, al progetto e alla società, portatrice di un’idea responsabile del proprio ruolo, rimane la chiave fondamentale per comprendere la lezione di Olivetti.
Per decenni abbiamo avuto ben altri rappresentanti dell’”imprenditoria”, per cui che si parli di Olivetti è buon segnale, confermato del resto dal successo di recenti iniziative editoriali, scientifiche e di studio a lui dedicate, e fatto ancora più importante che molti imprenditori tornino a guardare alla sua lezione, “facendo cose” olivettiane. Il rapporto fra cultura d’impresa e cultura del progetto è centrale per l’azienda di Ivrea, in verità più in generale per il design in Italia. Certo la concezione degli artefatti fisici e di comunicazione è vicenda complessa, spesso frutto di molte competenze e contributi, cui il designer attribuisce in sostanza una configurazione complessiva e definitiva, sintetizzando un processo e un lavoro di team. La macchina per scrivere Lettera 22 è stata disegnata da Marcello Nizzoli, ma vi hanno collaborato ingegneri, come Natale Capellaro, tecnici della produzione, grafici per la scelta dei colori e l’elaborazione degli strumenti di comunicazione, pubblicitari per gli slogan e molti altri, assieme naturalmente ad Adriano Olivetti che l’ha voluta fortemente.
Nella fiction, i prodotti – siano la macchina per scrivere o i manifesti – sono attribuiti a personaggi “di fantasia”, mentre naturalmente esistono designer che li hanno progettati che non compaiono né sono mai nominati, come del resto avviene per chi ha immaginato le architetture. Unica eccezione un cenno a Ettore Sottsass, come autore della “forma” dell’elaboratore elettronico Elea 9000. Perché mi sono chiesto? Di sicuro il racconto televisivo ha le sue regole – semplifica, semplifica, semplifica; esalta il protagonista, l’uomo forte, l’eroe senza macchia e senza paura; ci vuole una storia d’amore, guarda caso fra la finta-grafica e l’operaio-progettista; e così via – ma l’aspetto entusiasmante della vicenda di Olivetti, per cui merita di essere ricordato e indicato agli imprenditori e alla società contemporanea fondata sull’”economia della conoscenza”, è soprattutto “il gioco di squadra”, il network. Come cioè un industriale illuminato si circonda di alcune fra le migliori menti della sua generazione, a cominciare da architetti e designer. Anche da questa scelta nascono le fabbriche moderne e luminose, gli oggetti che molte persone hanno usato per lavorare in modo comodo e funzionale, una maniera di comunicare assieme artistica e innovativa.
Tutto questo il regista e sceneggiatore Michele Soavi, figlio di Giorgio Soavi storico collaboratore di Olivetti, aveva la possibilità di conoscere bene. E allora perché sprecare questa opportunità? Perché perdere l’occasione di una divulgazione corretta e un minimo colta? Se le storie non sono raccontate con un’adeguata articolazione e complessità, tutto si banalizza e diventa identico; in questo caso è la Storia ad uscirne falsificata. La scusa che il “pubblico vuole questo” o “queste sono le regole della televisione” non regge più da tempo né può essere accettata; innanzitutto perché nessuno possiede il riscontro che una cosa fatta diversamente sarebbe rifiutata. Bene allora parlare di Adriano Olivetti, uno degli industriali più noti nel mondo, pioniere del made in Italy e del design italiano; ma forse si poteva spendere un un po’ più di coraggio e orgoglio. Olivetti ne ha avuto molto e ha avuto ragione.
pubblicato su “Il fatto quotidiano”, 30 ottobre 2013
Ottobre 15th, 2013, category: Blog,
Nel giro di una settimana si sono tenute Maker faire a Roma eOperae a Torino, due manifestazioni espositive, di mercato, di laboratori e dibattito dedicate ai temi dell’autoproduzione, nel primo caso in particolare digitale, e delle possibilità di design “indipendente”.
Si tratta di termini e spazi teorico-operativi ancora in buona parte da chiarire e precisare, anche in relazione alle veloci trasformazioni e accadimenti in corso. Obiettivo comune prefigurare possibilità di progetto, produzione, distribuzione, consumo di merci e servizi che da una parte rispondano a esigenze, bisogni o necessità puntuali e non coperte dai prodotti mass-market, dall’altra recuperino il senso di un agire manuale e intellettuale individuale-collettivo in grado di delineare contesti meno massificati e alienati, più vicino alle singole persone. In questo modo tali approcci vanno oggettivamente esplorando modelli economico, sociali e culturali complementari e/o alternativi a quelli dominanti.
Al di là di qualche confusione, che ad esempio li ha mischiati con la rinnovata attenzione per il “saper fare” manuale e artigianale, autoproduzione e maker avevano già spopolato all’ultimo Salone del mobile di Milano. Per gli addetti ai lavori, e solo per rimanere in Italia, sono un ambito di attenzione e operatività ormai da tempo: la torinese Operae (quest’anno nelle spettacolari officine Ogr, ex Fiat) è alla quarta edizione; analoghe iniziative milanesi si sono succedute negli ultimi anni attorno a molteplici ricerche teoriche e progettuali, a cominciare fra gli altri da quelle ispirate da Stefano Maffei; datano ormai 2005 il progetto e il successo internazionale della piattafroma hardware opensource Arduino di Massimo Banzi, che ha contributo al fenomeno dei Fab-Lab, laboratori digitali e fisicamente condivisi per autoproduzioni.
La prospettiva del Diy (Do-it-yourself) ha progressivamente costruito propri spazi: nella modalità analogica o in quella digitale della produzione 3d, ma anche nell’approccio più sofisticato del custom design e del fare su misura per esigenze specialissime al margine o fuori dalle logiche del mercato. Certo il concetto di maker introduce termini e prassi nuove: dall’idea di community di lavoro, fisicamente dentro i Fab Lab o virtualmente online, al progetto open source con molti padri, alle logiche crowd, di agire dentro la folla della rete, per mischiare conoscenze o recuperare risorse economiche.
Rimane utile a questo punto però l’esercizio di pensiero e conoscenza: per distinguere, per criticare, per affinare la qualità oltre alla quantità. Magari anche per mettere a disposizione qualche strumento nuovo per il sistema delle piccole e medie imprese, oggi in difficoltà. Senza che maker e autoproduzione divengano la panacea di ogni male. Come in verità sta già un po’ accadendo da parte di frettolosi comunicatori o uomini di economia; talvolta gli stessi che per molti anni ci hanno raccontato che il design era solo luxury oppure che era obbligatorio delocalizzare, essere dimensionalmente e finanziariamente grandi, e ancora puntare tutto sul valore del brand con investimenti massicci in comunicazione e pubblicità, nel frattempo distruggendo il “saper fare” produttivo e poi ricerca, innovazione e design. Maker e/o autoproduzione configurano solo una possibilità. Da non sprecare.
da “il fatto quotidiano”, 14 ottobre 2013